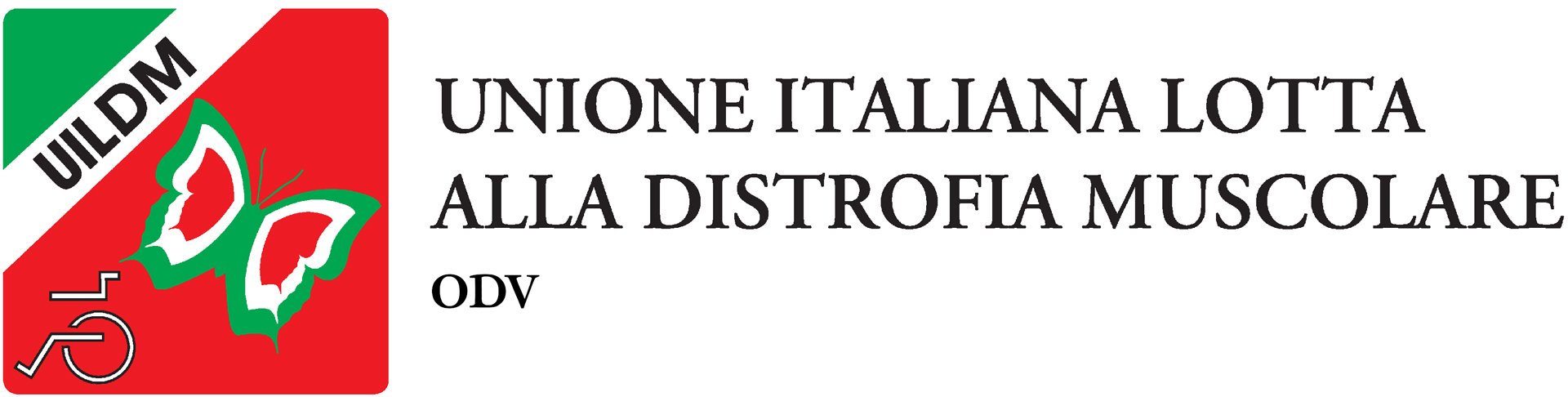di Mariangela Caroppo
Gaia, in una email, mi scrive:”Ci piacerebbe sapere quanto, secondo te, è diversa la visione da parte della società di una donna disabile a confronto con una donna normodotata”.
A me viene immediata l’associazione SOCIETA’ – VISIONE – IMMAGINE – PUBBLICITA’.
Nella pubblicità tutte le donne, ad eccezione di quelle che pubblicizzano profumi o gioielli, sono disabili:
• INCONTINENTI che hanno paura di entrare in ascensore, non perché soffrono di claustrofobia, ma perché preoccupate che si senta l’odore di pipì
• STITICHE costrette a ingurgitare ogni sorta di yogurt, solo dopo aver appreso il lessico fondamentale del latino (bifidus essensis, actiregularis…)
• CON LA DENTIERA non sempre ben incollata
• CON PRURITO VAGINALE che le rende tristi e impossibilitate a partecipare a qualunque evento sociale
• CON L’ASSORBENTE SBAGLIATO che le costringe a camminare guardandosi alle spalle
Al confronto io che ho:
• Una vescica perfetta
• Un intestino regolare
• Tutti i miei denti
• Le mestruazioni sono un vago ricordo
Potrei considerarmi una SUPERDONNA
Se però mi allontano dalle facili battute e torno sulla terra ecco che il mio ego si ridimensiona.
Lo spazio della donna all’interno della UILDM: la mia esperienza personale
Sarebbe stata interessante una riflessione collettiva delle donne che sporadicamente o con continuità hanno fatto parte della nostra Sezione, ma in quello che segue c’è soltanto la mia esperienza personale, il mio sentire.
Dal 2006, anche a Udine, la presenza femminile all’interno del Consiglio Direttivo è cresciuta: da una a due unità (su sette componenti).
Sono socia della UILDM dal 1985 e ho partecipato frequentemente ai Direttivi, prima come “invitata”, poi come Consigliera.
La composizione del Direttivo è stata, negli anni, più o meno costante: Presidente disabile, Vice Presidente medico, ex obiettori e, a turno, una donna disabile e non; anni fa c’è stato anche un genitore; spesso un Consigliere paraplegico, nostro socio attivo.
Nel corso degli anni mi sono occupata di scuola, nomenclatore tariffario, vita indipendente. Da cinque anni ho avviato la partecipazione a Idea Natale, una mostra mercato di oggettistica all’interno della Settimana della Solidarietà, che la Provincia di Udine organizza in prossimità del Natale. Occasione questa che ha dato i suoi frutti, non tanto in termini di raccolta fondi, quanto in termini di visibilità dell’Associazione e di aggregazione di un gruppo sempre più numeroso di volontari.
Partecipai al Corso di Formazione tenutosi a Colle Val d’Elsa nel 2002 in seguito al quale, con un gruppo di soci, tentammo di ridiscutere l’organizzazione della nostra Sezione senza riuscire a operare alcun cambiamento.
Nodo cruciale: la difficoltà nel passaggio delle conoscenze. La memoria, la conoscenza, l’esperienza erano patrimonio di uno solo ed era difficile operare un passaggio o una divisione / condivisione con i componenti del Direttivo o altri soci.
Non so e non credo che l’esperienza udinese sia unica nel suo genere e non ho risposte certe per spiegare questo empasse.
Però oggi qualcosa sta cambiando (più progetti, più referenti) e può essere utile una riflessione. I tempi forse erano maturi, una concomitanza di fattori diversi hanno determinato un nuovo modo di lavorare che è coinciso (casualmente?) con una presidenza al femminile.
L’aver nominato una donna come Presidente di Sezione significa automaticamente aver raggiunto la parità?
E’ la partecipazione al “potere” che porta alla parità? E’ questo che vogliamo?
Quale parità e all’interno di quale potere?
Partendo dal temine “Potere” e riflettendo su quali attributi lo caratterizzano, soprattutto nella percezione comune, ho cercato di individuare quali connotazioni possono ascriversi alla differenza di genere. E’ difficile questa operazione perché sicorre il rischio di semplificare qualcosa di complesso, di non cogliere le connessioni, le sovrapposizioni, le comunanze… La questione non è essere uomo o donna, ma comportarsi, muoversi all’interno di uno stile di vita maschile o femminile.
Una visione del potere, forse quella più comune, è quella di una equazione con i termini denaro, profitto privato, prestigio, protagonismo, visibilità e arroganza. Questa accezione, prettamente maschile, coinvolge, specie ultimamente, anche l’altro sesso sulla base di criteri estetici (le “veline” che, senza arte né parte, ma con arroganza, sono proiettate nell’agone politico e diventano le “quote rosa” di chi le ha sostenute).
Un’altra visione del potere, diametralmente opposta, è quella che associa alla parola termini come responsabilità, capacità di porsi degli obiettivi collettivi e perseguirli esponendosi in prima persona, mettendoci la faccia, per il bene comune.
La prima forma è caratterizzata da un decisionismo che non accetta le idee altrui, che sono vissute come pericolose e destabilizzanti; si tratta di una visione monolitica e unilaterale, tipica di chi crede di “possedere la verità” e la impone agli altri.
La seconda forma è basata maggiormente sulla condivisione e sulla partecipazione; le idee diverse vengono accettate e vissute come un arricchimento per tutti. Questa forma, a differenza della prima che porta all’esclusione, si apre all’accoglienza. Le dinamiche “politiche” in questo secondo caso divengono dinamiche “di servizio”.
E’ proprio della donna l’abitudine al “prendersi cura”, che non è mai tarpare le ali, non è sostituirsi, ma dare strumenti di autonomia, far camminare con le proprie gambe. Generalmente è proprio la donna, il suo essere madre, che riesce meglio a separare il bene privato da quello pubblico.
E’ questo un potere che allarga la base partecipativa, che è pronto a mettersi in discussione e a farsi anche da parte, se necessario, in un esercizio costante di libertà propria e altrui.
La parità sta nel fatto di riconoscere che la libertà è una pratica quotidiana che non si fida né di quote rosa né di facili traguardi, ma mette in discussione quelle conquiste che spesso sono concessioni per tacitare le coscienze.
L’Associazione e le donne: altra generazione o altro genere?
La nostra Associazione non è qualcosa di avulso dalla società, non è il profit o no profit a fare la differenza: sono, come dappertutto, gli uomini e le donne e la disabilità, a mio parere, acuisce la differenza di genere.
Forse non è se esistono ancora discriminazioni più o meno velate, più o meno confessate la domanda che dobbiamo porci, ma cosa vogliono le donne.
Pensiamo alla solitudine del potere. L’uomo come la donna sente il peso del lavoro, della responsabilità, ma l’uomo è più conservatore, più abitudinario, meno incline a modificare lo status quo, a intraprendere nuove strade; la donna si lascia sedurre, desidera e il desiderio è creativo. La creatività porta su strade sterrate perpercorrere le quali è necessaria la collaborazione e il sostegno di tutti.
Ciò che la donna chiede è ascolto e vicinanza, anche perché il carico emotivo, e non solo, è maggiore. L’uomo, per cultura, è “baciato dalla vita”: c’è sempre una donna che pensa a organizzargli la vita quotidiana e a sostenerlo. La donna, sempre per una cultura ormai parte del suo DNA, continua ad occuparsi della gestione domestica che sottrae tempo agli altri lavori o impegni sociali.
Tutto ciò, più che generare una consapevolezza delle proprie capacità, innesca sensi di colpa, sensazione di non fare mai abbastanza, di non essere all’altezza. Forse è questa una delle ragioni per cui le donne non fanno carriera. Ma, pur non raggiungendo i gradini più alti, i posti di potere, le donne lasciano sempre il segno del loro agire in tante buone prassi. Una buona prassi che ancora difetta è la fiducia in se stesse: sembra quasi che lo sforzo di generare e infondere fiducia al nascituro – futuro uomo – porti come conseguenza il non tenersi un briciolo di fede per sé.